
Ci vuole forza, le spiegai. Come in molte cose della vita. S’impara a camminare e a non cadere quando le gambe sono forti abbastanza. S’impara a masticare e a mandare giù bocconi sempre più grossi e amari. S’impara anche a sedersi e rimanere immobili quando non se ne ha assolutamente voglia. Pure questa è forza.
La vita è un’immensa vendemmia. Aspetti per mesi i frutti; in un solo giorno li recidi gonfi e dolciastri sotto i raggi caldi che fanno scintillare le foglie sfrangiate e il dorso lucido di piccoli ragni verdi che scappano disturbati. Poi la macina, i tini in cui il mosto fermenta bollendo e ti spezza la testa al primo respiro, se non sei abituato – eppure sai che non proverai mai piacere più grande di quell’ebbrezza fortigna che si mescola al sudore e al tepore pigro dell’autunno alla porte, mentre ti penetra torpido nella pelle. Infine il torchio, il terribile e maestoso torchio che tanto m’impressionava da bambino, da cui spremere un succo scuro e amaro impregnato di vinaccioli e raspi, e del sapore di un’esistenza segreta e nascosta che non riesci mai a comprendere fino in fondo.
Il torchio è la parola decisiva: più del mosto torbido e ambiguo e delle risate dei bambini che s’inseguono sotto le cupole delle vigne. La sbarra di ferro che ti scorre tra le dita, le reni che ad ogni colpo gemono, le vesciche che cominciano a formarsi, il secco e stereotipato “ta–tlak” che riempie l’aria assieme al fremito spumoso che filtra denso attraverso le assi di legno, cola gorgogliando sul piatto, scivola lungo il beccuccio metallico fin nella vasca. L’ultimo vino... E’ sempre stato il mio preferito. Forse perché concludeva un ciclo, e dava il meglio di sé, senza segni di stanchezza. Forse perché a produrlo tu eri costretto a dare il meglio di te stesso. Dopo di quello non restava altro che gettare le torte di bucce compresse al razzolare delle galline, e attendere novembre quando i tralci recisi lacrimano linfa, nei pomeriggi grigi e silenziosi passati ad annusare la nebbia.
Ci vuole forza, le ripetei. Volle provare a tutti i costi. La guardai sorridendo mentre diventava paonazza nel tirare a sé la sbarra cilindrica scrostata da molte mani. La aiutai. Creare assieme quel suono che tanto bene ricordavo e amavo fu una sorta di incantesimo rigenerato. Solo non c’erano più mio nonno, la sua terra, i miei genitori, gli zii e i cugini, non c’era più nessuno, a parte lei; persino le vigne erano state tagliate e lasciate morire perché nessuno aveva più tempo per occuparsene. E’ un peccato che non sia arrivata prima, nella mia vita. Si sarebbe divertita: mi sarebbe piaciuto farla appartenere a quel mondo della mia giovinezza con la sua magia di fine estate. Avrebbe forse capito molto di me…
Tornati a casa, stappai una delle bottiglie che ci aveva regalato il nostro amico. Aveva un vigneto sufficiente a coprire generosamente le necessità di un anno. La bottiglia era dell’anno precedente. Vino di torchio, l’ultimo. E’ uno dei pochi che, come me, pur senza capirne il motivo, l’ha sempre imbottigliato a parte.
Versai il vino in un calice. Lo guardai. Era caldo, scuro e rubescente come il sangue. Riluceva cristallino, simile ad una pietra antica. Lo respirai. L’aroma carico non stordiva, ma penetrava a fondo, facendosi strada lentamente, senza fretta, e s’insediava con tutta la sua forza intatta da qualche parte dell’anima e della memoria.
Lei si muoveva nella stanza. C’era qualcosa che mi si agitava nella testa, forse un ricordo, mille pensieri, una sensazione imprecisata ma sufficientemente importante. Sollevai il calice, e la osservai attraverso quel filtro ferrigno. Osservai la sua figura morbida e inebriante che si muoveva gonfia di vita e di fisicità. Sentii immediatamente crescere in me il desiderio. Portai il calice alla bocca, e senza staccare gli occhi da lei bevvi lentamente, assaporando ogni stilla come se fosse l’ultima, ascoltandola scendere nella gola, giù fino al ventre, e penetrare nel sangue con un’onda tiepida e calda che si dilatava sulla pelle.
Mi alzai. Andai da lei. La presi e la strinsi, avido. La baciai. Ci vuole forza nella vita, e la vita che le scorreva nelle vene e nella carne era mia, e la volevo. La volevo come il torchio brama il vino dall’ultima uva rimasta. Forse era questo il disperato segreto di quella macchina: un immenso, vorace desiderio di vita e di ubriachezza, per non sentire l’assurdità della solitudine e dell’esistenza.
La baciai. Ricambiò il mio bacio. Le sue labbra si schiusero sulle mie. Si staccò di colpo quando avvertì il dolore che le avevo provocato, mordendola. Inavvertitamente, forse. Forse, involontariamente, la morsi per farle male… Spostai la sua mano. Una goccia di sangue le scivolò sulla piega del labbro. Mi scusai. Mi avvicinai e la baciai delicatamente, proprio sulla ferita. Era una goccia della sua vita, della sua intimità, a scivolarmi dentro. Scura, calda, densa e rubescente come un ultimo vino. Lo stesso sapore.
La vita è un’immensa vendemmia. Aspetti per mesi i frutti; in un solo giorno li recidi gonfi e dolciastri sotto i raggi caldi che fanno scintillare le foglie sfrangiate e il dorso lucido di piccoli ragni verdi che scappano disturbati. Poi la macina, i tini in cui il mosto fermenta bollendo e ti spezza la testa al primo respiro, se non sei abituato – eppure sai che non proverai mai piacere più grande di quell’ebbrezza fortigna che si mescola al sudore e al tepore pigro dell’autunno alla porte, mentre ti penetra torpido nella pelle. Infine il torchio, il terribile e maestoso torchio che tanto m’impressionava da bambino, da cui spremere un succo scuro e amaro impregnato di vinaccioli e raspi, e del sapore di un’esistenza segreta e nascosta che non riesci mai a comprendere fino in fondo.
Il torchio è la parola decisiva: più del mosto torbido e ambiguo e delle risate dei bambini che s’inseguono sotto le cupole delle vigne. La sbarra di ferro che ti scorre tra le dita, le reni che ad ogni colpo gemono, le vesciche che cominciano a formarsi, il secco e stereotipato “ta–tlak” che riempie l’aria assieme al fremito spumoso che filtra denso attraverso le assi di legno, cola gorgogliando sul piatto, scivola lungo il beccuccio metallico fin nella vasca. L’ultimo vino... E’ sempre stato il mio preferito. Forse perché concludeva un ciclo, e dava il meglio di sé, senza segni di stanchezza. Forse perché a produrlo tu eri costretto a dare il meglio di te stesso. Dopo di quello non restava altro che gettare le torte di bucce compresse al razzolare delle galline, e attendere novembre quando i tralci recisi lacrimano linfa, nei pomeriggi grigi e silenziosi passati ad annusare la nebbia.
Ci vuole forza, le ripetei. Volle provare a tutti i costi. La guardai sorridendo mentre diventava paonazza nel tirare a sé la sbarra cilindrica scrostata da molte mani. La aiutai. Creare assieme quel suono che tanto bene ricordavo e amavo fu una sorta di incantesimo rigenerato. Solo non c’erano più mio nonno, la sua terra, i miei genitori, gli zii e i cugini, non c’era più nessuno, a parte lei; persino le vigne erano state tagliate e lasciate morire perché nessuno aveva più tempo per occuparsene. E’ un peccato che non sia arrivata prima, nella mia vita. Si sarebbe divertita: mi sarebbe piaciuto farla appartenere a quel mondo della mia giovinezza con la sua magia di fine estate. Avrebbe forse capito molto di me…
Tornati a casa, stappai una delle bottiglie che ci aveva regalato il nostro amico. Aveva un vigneto sufficiente a coprire generosamente le necessità di un anno. La bottiglia era dell’anno precedente. Vino di torchio, l’ultimo. E’ uno dei pochi che, come me, pur senza capirne il motivo, l’ha sempre imbottigliato a parte.
Versai il vino in un calice. Lo guardai. Era caldo, scuro e rubescente come il sangue. Riluceva cristallino, simile ad una pietra antica. Lo respirai. L’aroma carico non stordiva, ma penetrava a fondo, facendosi strada lentamente, senza fretta, e s’insediava con tutta la sua forza intatta da qualche parte dell’anima e della memoria.
Lei si muoveva nella stanza. C’era qualcosa che mi si agitava nella testa, forse un ricordo, mille pensieri, una sensazione imprecisata ma sufficientemente importante. Sollevai il calice, e la osservai attraverso quel filtro ferrigno. Osservai la sua figura morbida e inebriante che si muoveva gonfia di vita e di fisicità. Sentii immediatamente crescere in me il desiderio. Portai il calice alla bocca, e senza staccare gli occhi da lei bevvi lentamente, assaporando ogni stilla come se fosse l’ultima, ascoltandola scendere nella gola, giù fino al ventre, e penetrare nel sangue con un’onda tiepida e calda che si dilatava sulla pelle.
Mi alzai. Andai da lei. La presi e la strinsi, avido. La baciai. Ci vuole forza nella vita, e la vita che le scorreva nelle vene e nella carne era mia, e la volevo. La volevo come il torchio brama il vino dall’ultima uva rimasta. Forse era questo il disperato segreto di quella macchina: un immenso, vorace desiderio di vita e di ubriachezza, per non sentire l’assurdità della solitudine e dell’esistenza.
La baciai. Ricambiò il mio bacio. Le sue labbra si schiusero sulle mie. Si staccò di colpo quando avvertì il dolore che le avevo provocato, mordendola. Inavvertitamente, forse. Forse, involontariamente, la morsi per farle male… Spostai la sua mano. Una goccia di sangue le scivolò sulla piega del labbro. Mi scusai. Mi avvicinai e la baciai delicatamente, proprio sulla ferita. Era una goccia della sua vita, della sua intimità, a scivolarmi dentro. Scura, calda, densa e rubescente come un ultimo vino. Lo stesso sapore.
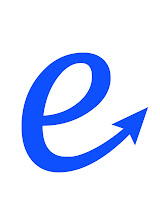

1 commento:
Molto bello. Forte e denso di vita.
un saluto
Daniel
Posta un commento