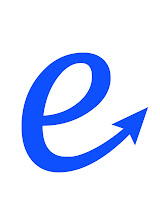Il buio è per molti l’unica possibilità, e lì, anche a costo d’inventarla, devi trovare la luce. Ho sempre creduto che nell’animo risieda la vera forza degli uomini, e l’animo prescinde dall’età. Domenica mattina, come ogni fine settimana accompagno mio nipote al parco di fronte casa. Vorrei portarlo in posti più belli, ma sono vecchio e stanco. In fin dei conti, per lui non conta molto la bellezza. Mio nipote Marco è cieco dalla nascita, per lui bello è ciò che gli provoca delle emozioni. Oggi ha undici anni, e vederlo lì, che vorrebbe infilare il cappotto da solo ma non riesce, fa male. Prende il suo bastone posato accanto alla porta, saluta tutti sorridendo. A volte mi domando se lui abbia coscienza del fatto che sorride sempre. Io da anni ho smesso di farlo. Mi vien da pensare che solo a pochi è concesso, sorridere intendo; ai bimbi, agli innamorati prima dell’inevitabile dolore, agli stolti.
Scendiamo in strada, attraversiamo la carreggiata e imbocchiamo il vialetto d’ingresso. Il parco è piccolino, ideale per sguinzagliare figli e cani. Alle nostre spalle, tre grossi pioppi ci separano dalla strada, mentre due pruni fanno ombra a una panchina costeggiata dal vialetto che attraversa tutto il parco. Una siepe svestita recinta la zona. Veniamo qui perché è comodo, sicuro. Vogliamo solo prendere un po’ di sole, e quello è uguale dappertutto.
Stamattina Marco è più allegro del solito. Attorno, voci di bambini attraggono la sua attenzione, ma lui sa bene che non potrà andrà da loro, almeno da solo. È incredibile come sia coscienzioso. Allora mi tira con tutte le forze racchiuse nell’esile braccio destro, mentre con la mano sinistra fa ondeggiare il bastone davanti a sé.
- Dai, andiamo nonno, è già tardi.
- Vai piano, lo sai che non posso correre.
Dovrei essere solo io a non poter correre. Ci fermiamo sotto due tigli al centro di un’aiuola. Marco posa il suo bastone a un tronco e scappa via inseguendo le voci degli alti bambini. Ha il sorriso di chi rivede una persona cara dopo anni, la gioia sincera della fine di un’attesa. Il sole compie i suoi sforzi per inondargli gli occhi, ma le palpebre di Marco restano serrate. Il buio resta buio se luce non puoi vedere, ma il buio diventa luce se luce sai vedere. Marco ce l’ha, Marco ha quella forza capace di cambiare il mondo che lo circonda. Spinge le sue gambe una davanti all’altra rincorrendo le altre voci, a bocca aperta per respirare più velocemente e arrivare subito, prima che tutto scompaia e finisca. Io resto a guardarlo poggiandomi a un albero, la schiena mi fa male, sono stanco. Penso a mio nipote, al fatto che probabilmente va incontro a un’altra delusione. Marco non può vedere quando la sua corsa arriva a destinazione, ma può sentirlo, e non più dalle voci dei bambini, ma dal loro silenzio, spontanea conseguenza nel vedere una persona diversa. I bambini si ammutoliscono alla vista di Marco, che si fa avanti a braccia tese cercando qualcuno, sorridendo, come gli innamorati. Non so se potrà mai conoscere l’amore per una donna, non so se ci sarà mai una donna disposta ad amarlo. Per stargli accanto bisogna accettare una serie di circostanze, sacrifici, compromessi con se stessi.
Marco si avvicina a un bambino, gli tocca il viso, gli chiede come si chiama ma l’altro non risponde, gli chiede che stanno facendo, ma tutti tacciono. Di colpo il bambino fa qualche passo indietro e si allontana di corsa seguito dagli altri. Marco ascolta il rumore dei passi che si allontanano e delle voci che riprendono i loro giochi d’allegria lontano da lui, dal diverso. Marco tende ancora le braccia in avanti, ma non trova nessuno. L’amore è troppe volte seguito dalla disperazione.
- Nonno.
Ha un mare di lacrime chiuse nella gola.
- Sono qui.
Gli vado incontro, lui corre verso di me, inciampa a un gradino, cade, piange. Si è graffiato le mani.
- Alzati non è niente, ti sei solo un po’ sporcato.
Marco si alza da solo senza dire una parola, si soffia sulle mani, mi abbraccia, singhiozza.
- Perché nessun vuol giocare con me.
- Perché gli uomini hanno paura di chi è diverso.
- Non è giusto però, tutti sono diversi da me ma io mica ho paura di loro.
Che dire?
- Perché tu sei speciale. Vieni torniamo a casa.
Ci incamminiamo verso i tigli per recuperare le nostre cose, ma di colpo Marco si ferma e si siede a terra. Dice di voler giocare almeno un po’ prima di andare, dice che noi possiamo divertirci anche senza gli altri bambini. Non so che fare, resto in silenzio. Mi rendo conto che aspetta una mia risposta, ma resto muto. Lui abbassa la testa, singhiozza, si alza in piedi e si incammina da solo.
- Marco aspettami, non correre.
Non mi ascolta e capisco che ora il mio compito è far divertire mio nipote, io, che ho settant’otto anni e che non so più ridere.
- Va bene, inventiamoci un gioco.
Marco si gira di scatto, sorride, corre verso di me e mi afferra per una manica. Dice di voler raccogliere delle pietre da buttare nella fontana. Lo assecondo e insieme arriviamo sotto i tigli. Mi spiega il senso del gioco. Credo di non averlo capito molto bene, visto che vorrebbe riempire la fontana di pietre in modo da far uscire tutta l’acqua. Mentre mi parla mi tocca il viso, e sento le sue morbide mani sulla mia pelle rinsecchita, sento la primavera addosso dopo l’inverno, rinascere i germogli della speranza. Marco ha una forza che non ho visto in nessun altro. Mi chiede di portarlo verso il viottolo di ghiaia. Andiamo, mi metto dietro le sue spalle e lo aiuto ad abbassarsi mettendogli le mani sotto le braccia per indirizzare le sue dita verso le pietre più grosse. Stringo i denti per le tremende fitte alla schiena, ma Marco ride, e a me non serve più nulla. Andiamo davanti alla fontana, lanciamo le pietre dentro e ridiamo per qualche schizzo che ci bagna i cappotti.
Spero che almeno questo amore non conosca mai la disperazione della fine.

 Questo è forse tra i migliori numeri del nostro blog. Racconti potenti, taglienti e allo steso tempo con un velo d''ironia. La redazione di ad est dell'equatore porge i più sinceri complimenti agli autori e rivolge un grazie a tutti coloro che hanno tempestato la nostra posta elettronica di racconti. Continuate a farlo, questo del blog sta diventando uno dei mezzi più importanti per scoprire talenti e dare l'opportunità a tutti di lasciarli scoprire. Grazie mille. Continuate a scrivere, a commentare, a votare e soprattutto a leggere.
Questo è forse tra i migliori numeri del nostro blog. Racconti potenti, taglienti e allo steso tempo con un velo d''ironia. La redazione di ad est dell'equatore porge i più sinceri complimenti agli autori e rivolge un grazie a tutti coloro che hanno tempestato la nostra posta elettronica di racconti. Continuate a farlo, questo del blog sta diventando uno dei mezzi più importanti per scoprire talenti e dare l'opportunità a tutti di lasciarli scoprire. Grazie mille. Continuate a scrivere, a commentare, a votare e soprattutto a leggere.